La bella fotografia funziona ancora oggi per raccontare i drammi del mondo?

Ho appena finito di leggere un articolo molto interessante che, anche se non lo condivido interamente, apre una riflessione importante sul ‘perché’ si fa una certa fotografia: dallo sviluppo in Photoshop alla didascalizzazione. Non sono un foto giornalista e non faccio news ma, oltre a fotografare matrimoni, da sempre sono interessato alla fotografia documentaria e al racconto fotografico. Ho un linguaggio narrativo abbastanza classico, semplice e forse è proprio per questo che quello che ho letto mi ha molto colpito.
L’articolo prende spunto dalle immagini di Kevin Frayer relativamente al suo lavoro sul genocidio dei Rohingya che è stato pubblicato su numerosi magazine, dal Guardian al Time. Le fotografie sono perfette nella sua composizione ed estetica e ricordano molto i lavori ‘intorno all’Uomo’ del primo Salgado. Suchitra Vijayan, fotografa a sua volta e autrice dell’articolo, si pone alcune domande anzi, per la verità, più che chiedersi afferma e, invece di aprire un dibattito in generale, attacca in modo pesante il modo con cui Frayer ha presentato il suo lavoro. ‘C’è molto di sbagliato in queste immagini, soprattutto la loro estetica’. Quella perfezione dello scatto accentuata dal processo di sviluppo. ‘La prima cosa che ti colpisce è la natura altamente texturizzata delle immagini, della grana artificiale e del dolore umano catturato e reso in alta definizione. Il dolore è esibito… L’estetica qui riduce completamente le ragioni dell’esodo dei Rohingya a un “accattivante” teatrino. Non ci sono nomi.’ Le didascalie non portano infatti alcun nome di persona, ma solo indicazioni generali e talvolta piuttosto banali.
Poi cita la lezione della scrittrice Maaza Mengiste che si chiede il perché si utilizza una particolare post produzione per raccontare fotograficamente certi gruppi di persone: Neri, Senzatetto, Poveri, Africani americani tutti con un bianco e nero esasperato, con la pelle scura e le rughe del volto volutamente enfatizzate e con il bianco degli occhi accentuato. Cosa si vuole sottolineare con questo processo? Perché un fotografo utilizza questo modo di post produrre? Credo che siano domande importanti a cui ognuno di noi dovrebbe dare una risposta.
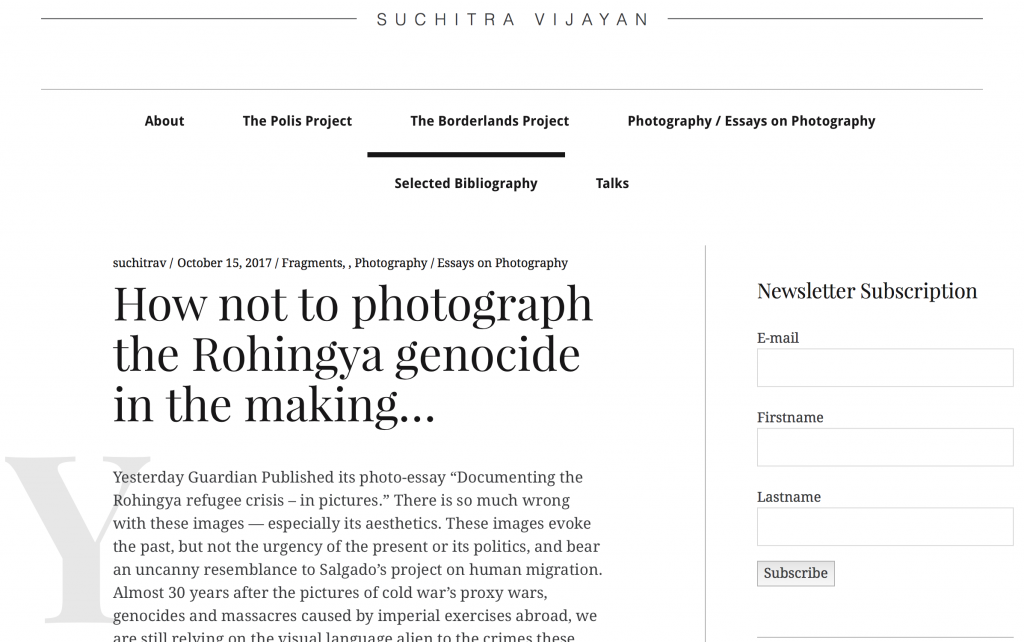
Suchitra si pone poi un problema che è stato ampiamente discusso parlando di etica nel foto giornalismo: le persone fotografate nella loro intimità erano consapevoli di essere sbattute in ‘prima pagina’ su alcuni tra i più importanti magazine internazionali? Veramente questo modo di fare fotografia aiuta – come è stato in passato per le immagini dal Vietnam, dal Biafra, dalla Somalia aggiungo io – a sensibilizzare la politica su certi drammi? A distanza di decenni dal modo di raccontare guerre, genocidi e massacri di autori come Salgado, McCullin, Peress, Griffits si continua ad utilizzare lo stesso schema visuale, la stessa grammatica e sintassi visiva di allora. Possibile non si riesca a trovare un modo diverso di fare foto giornalismo, dove l’estetica dello scatto ha solo un valore marginale e non primario? Dove il dramma viene raccontato andando oltre i cliché di un’immagine classica e stereotipata? Dove il dolore viene più percepito e sentito che visto?
Infine affronta il problema delle didascalie che dovrebbero aggiungere qualcosa alla fotografia e non limitarsi a descriverla banalmente. Quello lo si vede e non c’è bisogno di ribadirlo nel testo. ‘Ho spesso sentito dire: “non dirmelo, mostramelo”. Nulla ha fatto più danni alla scrittura e al processo creativo di questa frase terribile.’ scrive ancora Suchitra. E su questo punto credo che ogni discussione sia superflua. Meglio non metterle.
La mia non è una critica – come invece fa pesantemente Suchitra – ad un mondo che vivo solo parzialmente, ma una domanda, un punto su cui fermarmi a riflettere. Perché questo articolo mi ha così colpito? Beh perché la ‘mia’ fotografia – e non parlo di quella legata al matrimonio che ha delle dinamiche diverse – mi sembra troppo ancorata a questo modo standard di raccontare. E’ comunque autoriale? Credo di sì. Credo che sia comunque riconoscibile, ma leggere questo articolo ha smosso qualcosa di profondo, ha sollecitato la necessità di sperimentare, di provare a capire se dentro di me c’è un modo nuovo, diverso – ma che comunque mi appartiene -, di vedere e raccontare il mondo.
Buona luce



